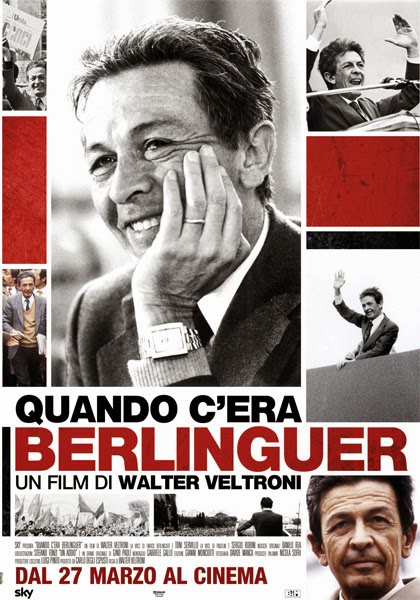Contano
più i legami di sangue o gli affetti che si cementano lentamente
nella vita passata assieme?
Voto
***½ 7½
Ryota
(Masaharu Fukyyama) è un benestante architetto in carriera. Dedica
più tempo ed attenzione al suo lavoro che non alla moglie (Machico
Ono) ed al suo piccolo figlio di cinque anni Keita (Keita Ninomiya).
E’ convinto che ordine e
disciplina siano fondamentali e che esser gentili sia un segno di
debolezza da evitare.
Forse
non è portato per il “mestiere” di padre ma il suo ruolo verrà
messo davvero a dura prova quando i dirigenti dell’ospedale, dove
anni addietro partorì sua moglie, gli comunicheranno che - a causa
dell’errore di una infermiera - il bambino che ha cresciuto non è
suo figlio bensì quello di uno squattrinato commerciante di
periferia che, a sua volta, ha subito la stessa sorte ed ha allevato
il figlio di Ryota.
“Father
and son” di Hirokazu Kore-eda
(titolo originale “Like father, like son: perché cambiarlo?)
riflette sui legami affettivi e
su quelli di sangue,
domandandosi se per un figlio contino di più coloro che lo crescono
oppure chi biologicamente l'ha messo al mondo, guardando anche al
ruolo dei genitori quando questi si trovano a confrontarsi con
difficoltà non certo comuni ed ardue a superarsi.
Vediamo
contrapposte due famiglie differenti per estrazione sociale, modo di
vivere e metodologie educative. L’attenzione è focalizzata
soprattutto sui padri: uno è un perdigiorno che vive all’impronta
le sue giornate, passa molto tempo a divertirsi con i suoi figli e sa
quanto sia importante far volare un aquilone; l’altro è
completamente offuscato dalle sue aspettative e assegna “missioni”
al suo pargolo, cercando di formare in lui un carattere tenace
attraverso lo studio del pianoforte e la ricerca dell’eccellenza.
La
regia ha un tocco soave, la resa è realistica e di grande
semplicità; i movimenti di macchina controllati e di grande
essenzialità.
Dopo
un colpo di scena in tribunale la
vera rivelazione – quella che
cambierà ogni cosa - arriverà
per caso, osservando gli scatti di una macchina fotografica.
Solo allora tutto apparirà improvvisamente chiaro: che gli affetti
non possono esser imposti per natura e nemmeno “decisi” con
l'ausilio della sola razionalità.
In
amore, tra “sconosciuti” che
decidono di unirsi per sempre (…marito e moglie…) o consanguinei
obbligatoriamente apparentati per nascita l’unica
direzione giusta è quella che indica il cuore: non ci è mai
possibile scegliere davvero una strada ma dobbiamo far di tutto per
camminare al meglio lungo quella che ci è capitata.